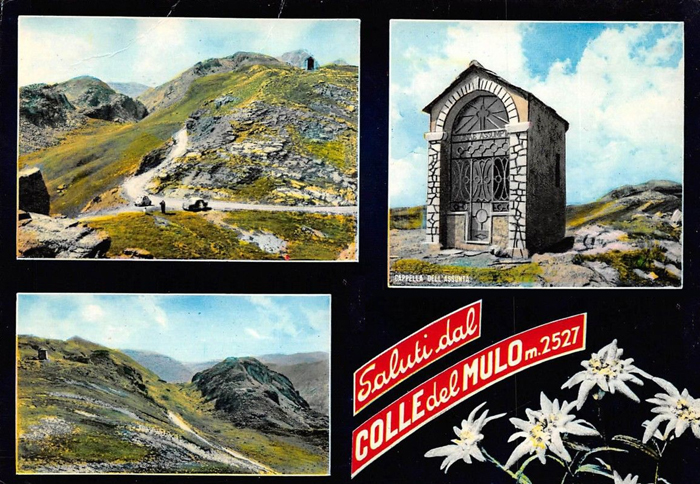|
Alzi
la mano chi non ha mai sentito parlare del Col del Mulo!
Eccetto i bambini dell'asilo, credo nessuno.
Però, è probabile che non tutti ne conoscano
la storia...
|
Le origini di questo valico
non sono per nulla chiare, infatti la memoria popolare da
sempre collocava questo toponimo nel luogo ove è attualmente
presente il Colle Fauniera, invece, secondo le cartografie
militari d'inizio novecento, questo sarebbe posto sullo spartiacque
delle valli Maira e Stura che unisce i comuni di Marmora
e Sambuco, i dati storici indicano che quest'ultimo sia
stato costruito dall'amministrazione militare piemontese intorno
al 1740, come segmento della Strada dei Cannoni o Napoleonica.
In quei tempi iniziava la guerra di successione d'Austria
e, causa le giravolte sabaude nelle alleanze, il cuneese si
ritrovò nel bel mezzo delle ritorsioni degli ex alleati
franco-spagnoli. Urgeva quindi una via di comunicazione
che collegasse le posizioni difensive della valle Varaita
con quella delle Barricate della valle Stura di Demonte e
che passasse attraverso la valle Maira.
Percorso per decenni da una mulattiera, venne interessato,
all'inizio degli anni '40, da lavori del genio militare per
costruzione
di una carrozzabile, quindi in concomitanza con quelli che
si stavano svolgendo sul versante di Castelmagno verso l'attuale
Fauniera.
Questi lavori però non videro mai la conclusione
e vennero interrotti a poche centinaia di metri dalla
vetta a causa dell'inizio degli eventi bellici del 1943.
A questo punto per capirci qualcosa occorre iniziare a
scavare a ritroso nella storia negli anni antecedenti il 1900.
Quest'ultima, raccontata e documentata negli Atti
Ufficiali
del Regno di Sardegna (1720-1861) di cui il Piemonte faceva
parte,
ci permette di scoprire che già alla metà del
1700, alla confluenza delle valli Grana, Maira e Stura
esistevano ben due Colli denominati "del Mulo":uno
di questi era il "Colle del Mulo di Castelmagno",
l'altro il "Colle del Mulo di La Marmora o Prà
Giordan", insomma due colli gemelli.
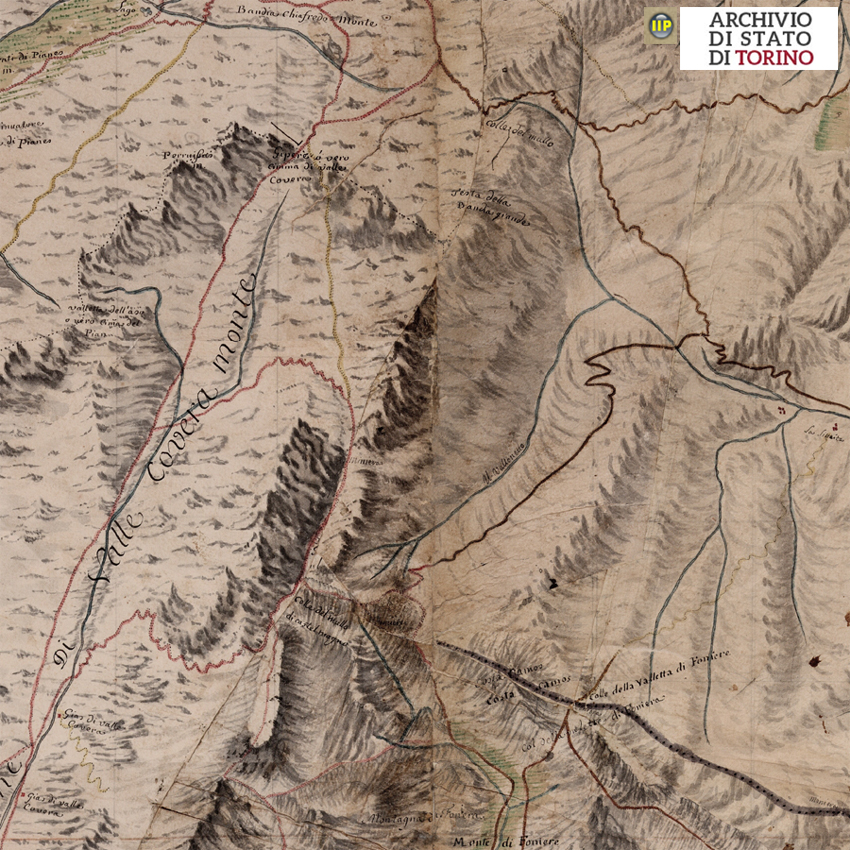 cliccare
sull'immagine per ingrandire la mappa
cliccare
sull'immagine per ingrandire la mappa
La storia ci riporta alla metà del 1700 epoca
della nascita dello Stato Sardo o Regno di Sardegna
e ci narra che
il Re Sabaudo, tra il 1738 e il 1744, nomina gli ingegneri
Giuseppe Celoniano, Antoine Durieu, Giovan Battista
Sottis,
Domenico Carello, Giovanni Giacomo Cantù per
l'elaborazione della
"Carta del Piemonte occidentale, dalla frontiera
del contado di Nizza sino
alla Valle di Lucerna, e da Cuneo a Saluzzo sino alle
frontiere di Francia",
comprendente le valli Gesso, Stura, Grana, Maira, Varaita
e Po, la carta è composta da 11 parti.
I lavori per rilevare, rappresentare e descrivere il
territorio procedono tra il 1745 e il 1757 durante le
campagne
contro i Gallo-Ispani: nella bella stagione sul campo,
in inverno nello studio per l'elaborazione dei dati.
Nelle vallate le squadre di lavoro sono composte da:
ingegnere topografo, traboccanti per le misure,
esperti locali per le informazioni, lavoratori per il
trasporto dei materiali.
La singole valli sono ricomposte in un unico quadro
di 672x744 cm.
Nell'affresco l'idrografia, la rete stradale e l'orografia
hanno linguaggio comune.
L'originale della Carta Storica è
conservato presso l'Archivio Di Stato di Torino
|
Ad esempio nel "Dizionario Corografico Universale…
degli "Stati Sardi di Terraferma" si legge
che:
La provincia di Cuneo… "Dal
passo dell`Aren, la linea gittasi per la valle del Piz alla
Stura e la varca rimpetto a Moraglione tra Pietraporzio che
ritiene nel controllo e Sambuco che lascia al concentrico.
Da Moraglione, che include nel raggio, si dirige, seguendo
le vette dell`Omo e di Val-covera, al Colle del Mulo,
superato il quale mettesi in Val di Grana e costeggia il torrente
fino a Castelmagno, tenendo nel controllo S. Anna col versante
a sinistra e lasciando
al concentrico le terre a destra."
La Valle Grana... "incomincia
la Colle del Mulo di Castelmagno e si estende
per circa 12 miglia fino a Caraglio, ove spiegasi in una pianura…"
Il Comune di Castelmagno... "facente
parte del Mandamento di Valgrana… Sorge alla sommità
della valle Grana. Il torrente Grana nasce appiè della
balza di Fontenera, e ingrossato di molti rigagnoli irriga
la valle a cui da il nome.
Il comune è circondato da monti che comunicano colle
valli di Stura e Magra. Alla loro estremità si eleva
il Colle del Mulo."
Nell'opera documentale "Notizie
Topografiche e statistiche sugli stati di Sua Maestà
il Re di Sardegna" al capitolo
"I mandamenti
della Valle di Macra",
giunti alla descrizione di LA Marmora si può
leggere:
" …La strada proveniente dalla valle di Vraita pei
colli d' Elva, varcata la Macra sul ponte detto della Catena,
attraversa questa vallicella e sale al Colle del Mulo,
detto anche di La-Marmora o di Prà-Giordano (alto
metri 2472) per quindi discendere nella valle di Grana a Castelmagno,
o nel Vallon dell'Alma lungo il torrente Canto a S. Giacomo
e Trinità di Demonte. Questa via pero è intercetta
da nevi e ghiacciai nell' invernale stagione. Sulla cima del
colle del Mulo si scorgono ancora le vestigia dei trinceramenti
eretti dalle truppe Sarde nella guerra del 1742…"
Sempre nella medesima documentazione
venivano descritti in questa maniera i confini della Valle
Stura con le valli Grana
e Maira:
"…Tra la valle di Stura e quella di Macra.
- I colli della Scaletta della Crocetta o Lausarotto, delle
Montagnette, del Vallonetto,
del Preit, il col Pianess, dei Cogni, dell'Ancoccia, del
Mulo di La Marmora o di Prà-Giordan, del Mulo di Valcovera
o del Mulo di Castelmagno…"
Tra la valle di Stura e la valle di Grana. - Il
Colle del Mulo di Castelmagno, il colle delle Cerese che
mette dal villaggio di S. Giacomo alle Cassine delle Cerese
ed a S. Pietro Monterosso; ed il colle dell'Ortica od Ortiga,
colle vie accessorie della valle di Grana…"
Ma di "Col del Mulo"
non si parlava e scriveva solamente nei documenti
dello "Stato Sardo", ma anche negli atti dei Comuni
della valle Grana..
Già in data 11 novembre 1792, da Caraglio, il
segretario comunale Giovan Battista Martini in una deliberazione
comunale facente riferimento ai danni degli eventi bellici
del 1744, ricordava:
"…che nella passata guerra
le truppe nemiche occuparono il Colle denominato del Mulo
posto nei limitrofi d'esso luogo di Castelmagno e delle due
valli di Macra e di Stura e quindi saccheggiarono la parrocchia
superiore del già detto luogo…".
Nel 1894 l'attento studioso di storia e tradizioni
locali, nonché Parroco di Castelmagno, Don Bernardino
Galaverna, nel suo libro "Cenni storici e tradizionali
intorno a S.Magno Martire Tebeo ed al paese e Santuario di
Castelmagno" già scriveva:
"… se più oltre
si continuasse a seguire il corso del Grana, dopo due ore
si giungerebbe la sua sorgente, sotto la balza detta Fontenera,
e dopo circa un'altra ora si arriverebbe al nodo principale
del Colle del Mulo, ove finisce il territorio di Castelmagno."
Erano passati poco più di un centinaio di anni dai
tragici eventi del 1744, ma nessun accenno alla presenza di
un eventuale Colle dei Morti.
Mentre in tempi più recenti, ne sono testimonianza
le numerosissime cartoline, alcune ancora in bianco e nero,
con la famosa frase di rito "Saluti dal Colle del
Mulo".
Da rimarcare il fatto che,
per ben oltre un secolo, con il nome Col del Mulo, per le
genti delle valli, del Piemonte e della Liguria, non veniva
inteso solamente l'attuale Fauniera, ma l'intero territorio
di confluenza delle valli Stura, Maira e Grana.
Rimane da chiedersi
come mai, nel passaggio tra il regno di Sardegna e quello
che poi sarà l'odierno stato Italiano, i cartografi
militari non trascrissero sulle cartine ufficiali tutte queste
minuziose descrizioni e, nel caso in questione, denominassero
come Colle del Mulo quello attualmente riportato su tutte
le cartine e non quello ben presente nella memoria popolare…
rimasto "innominato" per decenni sulle cartine ufficiali.
E' altresì curioso il fatto che, gli stessi militari,
definissero Colle del Mulo l'attuale Fauniera e non già
quello riportato nelle "loro" cartine, lo testimonia
il libro "Memorie di Caporal Maggiore"
di Giulio Patrizia che, raccontando il suo "periodo di
naja" dal 1938 al 1944 in provincia di Cuneo,
ad un certo punto scrive:
"Luglio 1937: Il '19 luglio
si parte per i campi estivi: da Cuneo a Monterosso Grana.
Passo la prima notte sotto la tenda:
dormo benissimo in un bel letto fatto di paglia: ci eravamo
accampati sotto gli alberi sulla riva sinistra del torrente
Grana
(a destra arrivando da Cuneo), poco prima del paese.
Il 20: marcia al Colle dell'Ortica nel vallone di S. Pietro
e ritorno fino a Pradleves. Questa marcia per me ed altre
reclute non abituate a camminare in montagna risulta molto
faticosa.
Il 21 riposo a Pradleves. ll 22 si sale a Castelmagno, tratto
non lungo e, già un po' allenato, mi sono stancato
meno.
Il 23 riposo a Castelmagno: un sole splendido e molti, specie
i Toscani, approfittano per farsi la tintarella al sole...
(tanto da spelarsi bene le spalle!), non io però.
Il 24 da Castelmagno verso la Bandia, passando per i Colli
del Mulo e Valcavera."
Come per "l'altro" Colle, anche questo rimase
una mulattiera fino all'estate 1940, epoca in cui questa
viene sostituita da una carrozzabile, denominata Strada
Militare 208, proveniente dal Santuario di Castelmagno
e diretta al Colle Valcavera.
Dopo aver consultato alcuni
ex cartografi dell'Istituto Geografico Militare, si
è giunti alla conclusione che la denominazione di passi
o colli veniva genericamente assegnata dall'IGM se questi
univano valli orografiche diverse o se cadevano sui confini
di comuni diversi tra loro e ben separati a livello di amministrazione.
Quelli che univano due versanti della montagna, ma erano compresi
sotto lo stesso Comune, non venivano nominati, in quanto l'eventuale
denominazione competeva alle autorità comunali.
Detto ciò, è storia che, dopo la costruzione
della nuova carrozzabile, né lo stato maggiore
dell'esercito, ma neanche le amministrazioni comunali di Castelmagno
e Demonte, probabilmente visto l'avvicinarsi della Grande
guerra, ebbero tempo di pensare in maniera ponderata al battesimo
e all'inserimento nelle cartine ufficiali di entrambi i
Colli dal nome gemello.
Tant'è che su tutte le cartine dell'Istituto Geografico
Militare e del successivo Istituto Geografico Civile il luogo
su cui sorgeva il cosiddetto "Colle del Mulo di Castelmagno"
rimase desolatamente vuoto dall'inizio del 1900 fin oltre
la metà degli anni '80.
Di conseguenza, se la dicitura Colle dei Morti compare in
qualche Cartina
commerciale a
seguito degli anni '90, è solamente per iniziativa
personale di qualche cartografo, che ha trattato in maniera
superficiale informazioni errate.
Ufficialmente il Colle dei
Morti non esiste e non è mai esistito, ed è
per questo motivo che non compare in alcun atto e in alcuna
Cartina
Ufficiale di
Comuni, Provincia e Regione Piemonte.
Ben chiara e documentata
è invece la storia del "Vallone dei Morti".
Il suo nome è dovuto ai moltissimi soldati caduti nella
guerra di successione austriaca, quando i franco-spagnoli,
passando attraverso
i piani della Bandia, oltrepassarono il Colle di Valcavera
per dirigersi ad assediare Cuneo.
Era il 1744. Padroni della contea di Nizza, i franco-spagnoli,
cui era stato ordinato di invadere il Piemonte, il 22 luglio
partirono dal territorio francese e si avviarono verso
Demonte.
Il 6 Agosto, in uno scontro assai sanguinoso,
avvenuto nel vallone a ridosso del Colle Valcavera, riuscirono
a sfondare il tentativo di sbarramento operato dalle truppe
piemontesi e occuparono le alture di Demonte.
Da qui l'appellativo Vallone dei Morti.
Questa Battaglia
è
descritta in maniera molto dettagliata nel libro "La
Valle Grana nei Secoli", di Don Maurizio Ristorto.
Tra le varie cose, possiamo leggere:
"…Ancora oggi a Castelmagno
si ricorda "il vallone dei morti" ove più
aspro sarebbe stato il combattimento e più numerosi
i caduti. Nella notte, il marchese Pallavicini di Frabosa,
al comando delle truppe piemontesi, sia perché teme
di non poter tenere la posizione sia perché gli mancano
le munizioni, ordina la ritirata; i Francesi, avvicinatisi
fino verso i nostri trinceramenti, non udendo alcun rumore,
vi penetrano dentro e, trovatili sguerniti, allo spuntare
del 18 si danno ad inseguire i Piemontesi ai quali fanno alcuni
prigionieri.
A pagare lo scotto di quei combattimenti sono le frazioni
Chiappi e Chiotti di Castelmagno che vengono saccheggiate
dai Francesi; Il nemico non ardisce scendere per Valle Grana,
ma tanto e il timore incusso nei paesani che il Comune
di Valgrana decide d"inviare 15 guastatori a rompere
la strada che da Castelmagno porta a Caraglio…"
Intanto a Demonte, il comandante Della Piazza, temendo il
peggio, lasciò a presidio del forte un migliaio di
soldati, fece saltare il
Ponte sull'Olla e col rimanente delle sue truppe ripiegò
a Cuneo.
Il 9 Agosto i franco-spagnoli assediarono la fortezza,
che una settimana dopo si arrese.
A distanza di un mese, il 9 Settembre, iniziò l'assalto
alla fortezza di Cuneo.
L'assedio durò dal 13 settembre al 21 ottobre.
Durante esso i franco-spagnoli vinsero la battaglia di
Madonna dell'Olmo (29-30 settembre), ma non riuscirono
a espugnare la città e furono costretti ad abbandonare
l'intento, ripiegando in Francia il 21 ottobre 1744.